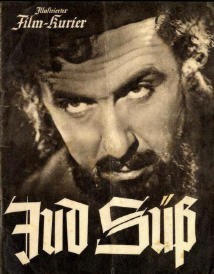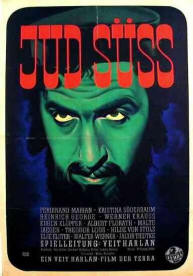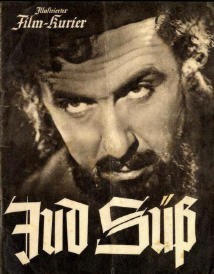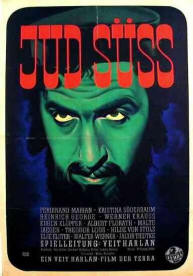| |
Quando ho conosciuto
Beniamino, anzi per me sempre Mimmino, egli era il lord protettore, la
guida spirituale, il tramite con il mondo di una comunità di singolari
studenti universitari lucani addensati tra Piazza Bologna e Piazzale
delle Province.
Ci avviavamo verso la metà
degli anni Cinquanta, e chi arrivava a Roma, e tra questi c'ero
anch'io, conosceva variegati riti d'iniziazione, ovviamente legati ad
un passaggio dalla provincia alla grande città che allora era davvero
l'immersione in una dimensione del tutto diversa, poiché lo scarto tra
quelle due realtà non era mediato e ridotto da un sistema dei mezzi
d'informazione che consentiva di trasmettere e rendere subito comuni
conoscenze e esperienze. Si entrava in un altro mondo e, per chi
avesse questa propensione, si sviluppavano mille curiosità.
Mimmino mi apparve subito
come chi delle curiosità si era impadronito, e ne aveva sviluppato un
singolare metodo di governo. Se il tramite per arrivare a lui erano
stati i "lucani", subito mi apparve saldamente insediato in
quell'altro mondo, che percorreva con levità, ma senza compiacenze o
concessioni. Se ci fu qualcosa che me lo fece subito sentire vicino,
questo fu proprio il bisogno di gettare l'occhio su tutto, o quasi,
senza esclusioni intellettualistiche o snobistiche. E dunque
avanspettacolo e grande critica letteraria, calcio e università,
generi nascenti ed esperienze in via d' estinzione, attenzione
politica e rigoroso pettegolezzo. Discutendo o chiacchierando con lui,
si avvertiva che egli non proponeva gerarchie, ma criteri rigorosi di
giudizio. Se di tutto era legittimo interessarsi, questo non
autorizzava l'ingagglioffirsi, né il legittimo pettegolezzo permetteva
di guardare alla storia o alla politica con l'occhio del cameriere. E
così, senza farli pesare, cadevano il riferimento o la citazione per
mettere nel posto giusto lo spettacolo di rivista, il romanzo appena
uscito, un dibattito parlamentare.
Non mi sembrò strano,
quindi, che egli diventasse acclamato e temuto critico non solo della
sua amatissima letteratura americana, ma di quello che davvero gli
appariva il "nuovo mondo" dei tempi nostri, la televisione. Ha
inventato un genere dopo aver messo le mani sul nuovo mezzo, in
quell'allegra e rigorosissima mescolanza che sono state le sue
"serate". Veloce com'è sempre stato nel cogliere la sostanza delle
questioni, non ha mai trascurato i dettagli, ma mai ne è rimasto
prigioniero. Ne ebbi una prova diretta quando, all'epoca in cui
preparava il concorso per la Camera dei deputati, venne un paio di
volte a casa mia con l'argomento che voleva un po' saggiare la sua
preparazione nelle materie giuridiche. Fu subito evidente che delle
tecnicalità si era immediatamente impadronito, e davvero non gli
serviva alcun sostegno esterno. E così le nostre chiacchierate
divenivano un interrogarsi su quale fosse davvero il ruolo del diritto
costituzionale, quale la funzione del Parlamento e il modo in cui
tutto questo dava forma alla politica, e più ancora alla cultura che
doveva sostenerla.
Il mio tempo parlamentare
non ha coinciso con il suo. Quando divenni deputato, Mimmino aveva già
lasciato la Camera. Ma la nostra costante frequentazione, intensa in
particolare agli inizi degli anni Sessanta, si è svolta anche nei
luoghi parlamentari, allora assai più accessibili di adesso, dove
arrivavo come frequentatore della biblioteca o curioso di politica o
semplicemente come amico, scoprendo così non solo affinità tra le mie
prime ricerche sui computers e le sue pionieristiche iniziative per
l'informatizzazione dei servizi della Camera, ma pure l'attenzione e
il rispetto che per la sua cultura avevano tanti parlamentari (un
fatto che oggi mi sembra irripetibile).
Anche lì, si potrebbe dire
con espressione abusata, Mimmino era riuscito a divenire "punto di
riferimento", scavalcando e rendendo ridicole gerarchie e burocrazie.
Ma nella mia vita
parlamentare Mimmino ha un posto particolare, legato ad un episodio
assolutamente unico. Una mattina presto suonano alla porta di casa, ed
un fattorino mi consegna un bellissimo fascio di rose rosse. Apro il
biglietto che l'accompagnava, con un lieve senso di colpa perché
ritenevo di violare la riservatezza di mia moglie, e invece leggo
d'essere io il destinatario del dono, che Mimmino aveva voluto
mandarmi avendo letto su Il Manifesto il testo di un mio discorso alla
Camera del giorno prima.
Infrangendo una regola
rigidissima soprattutto tra meridionali - non ci si scambiano fiori
tra uomini, meno che mai rose rosse - Mimmino mi arrivava davvero al
cuore. Ed ho sempre voluto pensare che con quel gesto atipico volesse
sottolineare la singolarità della mia posizione parlamentare, una
sorta di irriducibilità agli schemi abituali. La sua costante
attitudine scherzosa non è mai sottovalutazione. Al contrario. E' il
modo per mostrare, con grazia, senza pedanteria, che non ci si deve
prendere troppo sul serio.
Le cose possono essere serie
e gravi, e come tali vanno trattate, senza però che questo consenta a
chi le tratta di mettersi pennacchi o salire a cavallo. Tanto più
grandi sono le cose, tanto maggiore dev'essere l'umiltà
nell'affrontarle. Forse mai come con lui l'ironia mi è apparsa così
nitidamente come la misura delle cose.
- STEFANO RODOTA' -
|
|